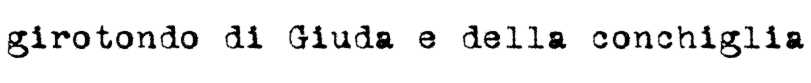

LA VOCE CHE NON PARLAVA PIÙ DA ANNI.
Ottenne di guardare il vento,
e non lo credeva possibile. Il mare al di sotto del faro era un respiro
ansimante, ripetitivo e ampio come il sospiro di Dio.
« Ascolta », disse improvvisamente la voce che non gli parlava
più da anni. « Il tuo cuore è una stanza di cui
non vedi il fondo. »
« Chi sei? », domandò spaventato. Si girò,
ma il silenzio e l’assenza abitavano dentro e fuori di lui, e
lui li conosceva. Allo stesso modo, senza alcuna pietà, riconobbe
il senso di impotenza che lo vinceva. E il tradimento — e lui
stesso era il traditore —, come una lama che ha appena tagliato
e non può tornare indietro; non può, il filo, come per
magia, ripercorrere il segno rosso, solcare all’inverso, dalla
fine al principio, l’incisione già fatta, e cicatrizzare
la ferita.
Sistemò lo sgabello davanti al cavalletto. Fissò la tela.
La luce di quell’ora filtrava fra la trama attraverso i verdi,
i gialli, gli azzurri. I colori erano gli elementi fusi in impasto,
pigmenti essenziali emessi dalla sua mente con l’aiuto delle dita.
Il quadro non ritraeva il panorama, né il cielo, e neppure il
faro. Vi appariva una spiaggia al tramonto, dune invase da cespugli,
un volo radente di gabbiano. E due figurine vestite alla marinara, fine
’800.
IL SUSSURRO IN MEZZO AL TEMPO.
«
Carlotta », chiamò la bimba più piccola,
quasi senza intonazione. « Carlotta », ripeté, ma senza
insistenza.
« Non chiamarmi Carlotta. Tu puoi chiamarmi come ti pare, ma non
Carlotta, no. Lo sai... »
Un piccolo broncio sotto il cappello blu-oltremare, solo un attimo.
« Però non vuol dire che non mi vuoi più bene se ti
chiamo Carlotta, vero? »
Stavolta la piccola guardò l’altra negli occhi, obbligandola
a fermarsi, a risponderle. Le due bambine erano ora girate l’una
dirimpetto all’altra; tacquero per un tempo imprecisato, lunghissimo,
i visini seri d’una serietà adulta. In quel momento sulle
loro espressioni giocavano vecchie radici, gestualità familiari
sempre dimenticate e sempre riprese. Nel tremito d’un labbro, negli
occhi socchiusi a fessura, gli antenati, i defunti, dilatavano i loro
sentieri scavalcando la morte.
« Io ti voglio bene lo stesso, Emma. »
La più grande si chinò a baciare la guancia della sorellina,
e aveva gli occhi di un azzurro terso in cui gli ultimi raggi del sole
non riuscivano a entrare.
Complici divertite, intonarono di colpo una cantilena sgangherata, senza
senso, pigiando e ripigiando i piccoli sandali nelle orme contrapposte.
Parole diseguali, recitate malamente a memoria, ripetute da chissà
quante generazioni, apprese a cavallo delle ginocchia di nonne e di zie,
ridendo.
Poi un girotondo, sempre più svelto e gioioso.
« Che bello, Carlotta! Che bello! »
E insieme giù per terra, un tonfo sulla sabbia.
Una voce lontana, di donna giovane, richiama le bimbe: è la fine
del giorno, dei giochi.
Troppo presto: un velo di tristezza, uno sbuffare. Con rassegnazione (o
forse insofferenza) si voltano verso la madre, un ampio cappello di paglia
chiara con un nastro turchese. Mentre arriva la fantesca, goffa e frettolosa
lungo i gradini che portano alla veranda dell’albergo, le due bimbe
si scambiano uno sguardo d’intesa; ciascuna, dentro sé, è
sicura che il ricordo di quell’istante, assieme a pochi altri frammenti
di memoria, l’accompagnerà sempre, d’ora in avanti,
ogni giorno della sua vita.
La piccola è sgomenta. Fissa la maggiore senza parlare, senza vedere.
Combatte contro due mezzelune di lacrime, con le sue palpebre inferiori,
altalene oscillate da un nuovo vento, che bisogna tenere allineate, e
ferme, in un nuovo gioco appena inventato.
Carlotta vorrebbe dire: « Scappiamo, Emma. Andiamo via adesso. »
Ma non le riesce. Allora sente nella sabbia, tra le dita, la madreperla
convessa d’una conchiglia, e la raccoglie. Non l’accosta all’orecchio:
è una meraviglia vecchia per lei. La conchiglia dev’essere
un dono, e l’icona di un attimo in mezzo al tempo.
« ’Lotta... »
Il sussurro del mare prosegue dalla piccola mano alla tempia di Emma,
estasiata.
LUNEDÌ, L’AZZURRITÀ.
Lunedì
Prima
di “partire” ho — hanno — gettato via tutto, rovesciato
i cassetti, svuotato la mente. In realtà vorrei che fosse così.
Non ci sono riuscito.
E questo è un diario o una lettera — l’ultima —
che ti sto lasciando?
Non ho mai avuto un diario, la costanza di tenerne uno. Un po’ come
gli album delle figurine pieni di riquadri bianchi, presagi di un voto
all’incompletezza. No, tu le definiresti delle spie del mio perfezionismo.
Non posso darti torto: ormai la vita dovrebbe avermi insegnato che non
c’è mai un inizio e una fine, che l’imperfezione è
la vera regola perché, forse, è l’unica.
Però sono così, e non posso più cambiare adesso.
Ci hai provato tu, D., a farmi cambiare, e forse è anche per questo
che è andata così.
Fra tutte le cose del cassetto è stata la conchiglia scheggiata
quella più penosa. La tiravi fuori di tanto in tanto, un ricordo
di tua madre probabilmente, la dolce Signora Emma, ma non vi ho mai fatto
molto caso. Me ne farai una colpa? Non mi importa, non più. A me
ha rammentato il mare, la casa che i miei avevano in affitto tutto l’anno,
le nostre prime intimità. Niente di buono, insomma. Le immagini
che ti sfilano davanti agli occhi ti dànno un’illusione perversa,
si divertono ad ingannare spazio e tempo. Ogni istante che ritorna è,
all’inizio, una specie di fotogramma indistinto, di cinematografo
fuori fuoco; ma poi si anima, e allora si svolge una scena che nessuno
ha richiesto, fatta soprattutto di colori, suoni, e volti. Ma volti imprecisi,
particolari in disordine: un caos di sorrisi, denti mostrati o nascosti,
sopracciglia, occhi, labbra serrate. La cosa più curiosa è
che ricordo perfettamente il mio volto, la mia espressione, come se io
osservassi me stesso da fuori.
L’idea di me — mentre ti prendo per mano, magari.
Lunedì
è il primo giorno. In ossequio al perfezionismo terminerò
domenica, ché è sempre stata la giornata più triste
della settimana. Scrivo guardando il mare, sempre diverso: devo riuscire
ad essere come il mare. Ho tentato, vi ho provato per una vita, ma ho
ottenuto soltanto di potervi tornare, ancora e ancora, e forse di vedere
qui il mio ultimo giorno.
Dicono che l’oceano sia differente: che ci si accorga subito dell’estensione,
dell’apertura che cattura lo sguardo. Io penso che è un fatto
di anima, l’anima dell’acqua. E poi la terra, che davanti
all’oceano si spinge — essa stessa — verso l’acqua,
si fa come una mano protesa all’infinito, all’azzurrità.
Esiste questa parola? Deve esistere, credo, ché da che mondo e
mondo sono state inventate, e dette, tutte le parole: solo, in ordine
sparso, senza una regola.
Ma non devo divagare. L’oceano e il mare, quello che sto guardando.
Il Tirreno non risucchia la costa perché è un mare chiuso.
Il Mediterraneo è un mare finito. Le rive sono i margini d’una
conca: Mediterraneo, in mezzo alle terre. Gli oceani, invece,
sono gli orli dei continenti, acque profili del mondo.
POMERIGGIO DI ACCIDIE E MENZOGNE.
Riprendo, sono le quattro forse. Non ho orologio — non posso tenerne uno —: calcolo il tempo dalla lunghezza dell’ombra, e dalla distanza dai pasti. Sto sempre peggio, mi addormento all’improvviso, qualsiasi cosa stia facendo. Crollo, precipito come un antico palazzo in rovina, ma non sento la caduta. Quando ritorno è solo il velo del sudore cattivo che ho indosso a darmi una vaga idea del tempo mancante. Allora mi giro con terrore verso la scodella, al solito posto. Se è vuota, o piena; se c’è il quarto di pane nero, o non c’è: questo è l’importante. Perché potrebbero tradirmi ancora, e negarmi il cibo — e così il senso del tempo — mentre brancolo alla cieca nella mia notte senza sogni.
Sono
le quattro. Forse. Ma di che giorno? Ho fame e la scodella è vuota.
Ma può darsi che abbia fame per questo, perché la vista
inganna lo stomaco con il deserto asciutto del piatto, perché il
ricordo dell’odore del pane è più reale del suo sapore
raffermo, ammuffito. Non ha più senso il conto del tempo? Luna,
Marte, Mercurio, Giove... Sei giorni pagani e l’ultimo, cristiano,
del Signore. Domenica. Dies Domini.
La domenica era il giorno consacrato — è l’aggettivo
giusto — al casino. Ricordi, D.? No, forse non l’hai mai saputo,
o magari fingevi di non saperlo. O ti andava bene. Molto più conveniente
così, certo. Forse ero soltanto io a dover — a voler? —
continuare a ingannare me stesso.
Sono ritornato dalla Corinna qualche mese prima di finire qui. Era tutto
diverso dall’ultima volta, tranne la decrepitezza della tenutaria
e i suoi modi frettolosi, sgarbati. « Di corsa, in camera, prendere
la ragazza, vai! Non me la farai mica invecchiare con la tappezzeria,
Amore, eh? »
Mi riconobbe subito, il solito sorrisetto, complice e schifato al tempo
stesso. Anzi, più schifato delle altre volte. Tutto diverso,
sì. Riviste di regime, qualche numero de « La Difesa della
Razza »; un busto nero del duce sulla colonnina di marmo dove ricordavo
una Leda oscena che si accoppiava col cigno; un grammofono che gracchiava,
nascosto chissà dove. Nessuna divisa però, e l’olezzo
— quello abituale, inconfondibile — del sudore mescolato ai
profumi da due soldi. E ragazze nuove — donne —, più
brutte, più rassegnate.
Ho scelto (o era rimasta, non so) una bruna triste, dal viso magro con
le sopracciglia disegnate, e siamo saliti al primo piano. L’ho pagata
e, come sempre, le ho chiesto di lasciarmi in pace, ma che restasse lì,
accanto a me, in silenzio.
Mi sono disteso sul letto, acceso una sigaretta — una delle ultime
da uomo libero. Avevo portato dei compiti da correggere, ma già
non ne avevo più voglia. Guardavo il baluginio azzurro sul soffitto,
i riflessi marini di quel pomeriggio di accidie e menzogne, filtrati dalle
persiane socchiuse.
La donna era seduta sul letto, ai miei piedi. Zitta, impiegava il tempo
che avevo comprato a rammendare l’orlo della sottoveste, senza togliersela.
Aveva le gambe grosse, le cosce sproporzionate rispetto al resto del corpo,
esile. Ed era bianca, bianca come il marmo dei gabinetti del casino. Pensai
— ricordo bene — alla pelle bruciata dei pescatori che passavano
sotto quelle finestre mezze chiuse, sogghignando magari o, più
probabilmente, tirando diritto nella via, immersi nei casi loro. Allora
mi sentii soffocare e balzai giù dal letto: spalancai la finestra
e mi riempii gli occhi col sole specchiato sulle onde.
SOGNO DEL TRENO E DEL MARE.
Mi presero l’indomani: non
riuscii neanche ad entrare in classe. Le facce grigie della polizia sfilarono
all’improvviso, come tessere opache di un domino odioso, fuori dalla
porta del direttore.
Santecurtò uscì per ultimo, dietro ai ceffi. Mi diede uno
sguardo dall’alto in basso, disgustato ma — ne fui certo —
con una punta di amarezza. Si passò la mano sulla pelata, ma non
era il gesto abituale: era come se una pagina — la pagina
— fosse stata voltata per sempre, definitivamente.
« È il maestro Fanti », assentì sottovoce, allo
sgherro con il cappello già in testa. « Mi raccomando, nei
corridoi... Il massimo silenzio, per favore... », aggiunse, rosso
in viso.
« Solo un controllo, Signor Maestro, tranquillo. »
Uno di loro era siciliano, palermitano mi sembrò. Allora —
chissà perché — pensai che era un uomo cresciuto accanto
al mare, che non mi poteva nuocere, e mi rassicurai. Non feci resistenza.
Non mi vennero in mente domande. Non mi girai neanche indietro, per un’ultima
occhiata alle aule, alla scuola.
Il resto — l’interrogatorio, lo scherno, gli insulti, le botte,
la “confessione”, la condanna — non hanno più
interesse per me. Qual è la mia colpa? Aver compreso che non potevi
fare altrimenti? Preferir pagare di persona, e da solo, un “peccato”
che non esiste, eppure esiste da sempre, come quello di nascere ebreo,
o zingaro?
La vergogna maggiore — ché spero tu, prima o poi, la possa
provare — è il fatto che io sia felice di non incrociare
gli occhi di mio padre. Perché è sottoterra da anni, lo
sai. E nessuno di questi corvi, neri fuori o dentro, gli si può
avvicinare e bisbigliare all’orecchio, subdolo, che ha un figlio
finocchio, pederasta, e amico dei giudei. Ché mio padre non capirebbe,
non potrebbe capire, e il sangue gli passerebbe a bile e lo avvelenerebbe,
ma senza ucciderlo se non a poco a poco, giorno dopo giorno, ora dopo
ora. Per avermi dato modo — lui stesso! — di aggirarmi ogni
mattina fra bimbi innocenti, ignari, ed ariani.
Perché siamo ariani noi. Noi Italiani. I nostri fratelli
sono i biondi nibelunghi dall’occhio chiaro e dall’odio senza
incertezza. Non i mediterranei bruni e tarchiati, figli di Cartagine,
o Creta, o di Alessandria. E tutta la faccenda di Enea, pio padre fondatore
di Roma, troiano e levantino, va riveduta, spiegata.
Era un pomeriggio d’accidia e di menzogna, quello in cui spalancai le persiane e ti vidi, piccola, meschina miniatura di uomo. Dipingevi presso il faro, D., dove spesso ti trascinava la tua inquietudine che amavo — ed amo tuttora — tanto. Adesso capisco che l’accidia e la menzogna — il mentire agli altri, e a se stessi — partoriscono l’inquietudine. Ed è la stessa che doveva far tremare Giuda prima che compisse il suo destino; anche se né tu sei Giuda, né io Gesù Cristo, ché questa sì sarebbe una menzogna, delle più grandi.
Qualcuno
— e il freddo che incombe — mi dice che dicembre s’avvicina.
Un giorno tutto questo finirà, ma noi non dimenticheremo, D., questo
1938 in cui tutto è rimasto uguale ed ogni cosa è cambiata,
tra falsità e indolenza.
A volte sogno, nei miei vuoti improvvisi, il treno di Hitler che entra
trionfalmente nella stazione Ostiense, fra trombe, parate, carri di Tespi
ed enormi M di luce — M come Menzogna. Ma non
è la stazione. Non è una stazione. È un mare, un
oceano rosso di sangue che vibra appena, potente ed elettrico, mentre
riflette un antico simbolo di luce che così appare specularmente,
a rovescio, e sembra una croce uncinata quando, invece, al positivo, al
diritto, sarebbe la svastica del sole.
Sì, D.: è imminente. Annegheremo, tutti, in questo mare
senza l’azzurro, senza conchiglie in cui udire la risacca.
Poi, forse, se Dio vorrà, se l’Uomo ricorderà,
potremo finalmente camminare accanto, senza paura o vergogna. E non vi
sarà più niente per cui tradire.